Come funziona un impianto fotovoltaico
Impianti fotovoltaici
Un impianto solare fotovoltaico converte la radiazione emanata dal sole
direttamente in energia elettrica utilizzabile dalle utenze domestiche. Ad oggi
esistono due tipologie di impianto:
- Impianti connessi alla rete elettrica
- Impianti ad isola (o stand alone)
Funzionamento per immissione in rete
Lo schema che
rappresenta l’impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica in
un’abitazione è quello di figura 1.
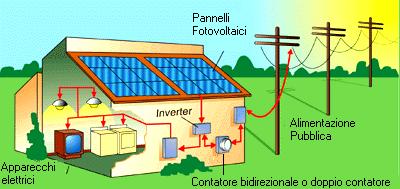 Figura1. Impianto Fotovoltaico
Connesso alla rete. Figura1. Impianto Fotovoltaico
Connesso alla rete.
Qui si possono distinguere i diversi
dispositivi che rendono funzionale l’impianto:
- Generatore fotovoltaico: è costituito dal collegamento di
moduli fotovoltaici ed è in grado di trasformare l’irraggiamento solare in
corrente elettrica continua.
- Convertitore statico DC/AC: converte la corrente elettrica
continua prodotta dai moduli in corrente elettrica alternata, quella cioè,
normalmente usata in ogni edificio. Il convertitore è anche in grado di
allineare la corrente elettrica alla frequenza di rete normalmente 50 Hz e alla
tensione di funzionamento (230V monofase, 400V trifase).
- Quadro elettrico: è l’elemento di protezione in lato
continuo ed in lato alternato dell’impianto. E’ costituito prevalentemente da
scaricatori di tensione e da interruttori automatici.
- Contatori: tipicamente sono installati due contatori; il
primo monitora tutta la corrente prodotta dall’impianto fotovoltaico. Questo
contatore, in linea di principio, è installato subito a valle dell’inverter. Al
contatore è associato il meccanismo di finanziamento statale. Il secondo
contatore sostituisce quello esistente della rete di distribuzione: è
bidirezionale per cui è in grado di fare un bilancio tra l’energia immessa
dall’impianto verso la rete elettrica, e quellaprelevata dalla rete elettrica
verso l’utenza. A questo secondo contatore è associato il risparmio sulla
bolletta elettrica.
In questo modo l’impianto fotovoltaico lavora in parallelo alla rete di
distribuzione che, sostanzialmente, funziona da accumulatore per l’energia
prodotta dall'impianto. Facciamo un esempio che chiarisce la metodologia di
funzionamento denominata "scambio sul posto":
è piena estate, il signor Gino ha un impianto fotovoltaico sulla sua
abitazione e oggi è tutto il giorno fuori per lavoro: tutta l’energia prodotta
dall'impianto e non utilizzata in casa, viene immessa nella rete di
distribuzione e contabilizzata in uscita dal contatore di scambio sul posto.
Domani il signor Gino è a casa e, dato il caldo, accenderà per tutto il giorno
il condizionatore. In questo caso potrà prelevare gratuitamente tutta l'energia
precedentemente immessa e il contatore di scambio contabilizza l'energia
prelevata dalla rete.
Ovviamente il conguaglio dell'energia (immessa e prelevata) va fatto su base
annuale; si deve ricordare, però, che l'impianto fotovoltaico per utenza
domestica deve essere sottodimensionato rispetto al fabbisogno energetico (circa
il 75% dei consumi) per almeno due motivi:
- il costo dei primi 900 KWh incide con una percentuale più bassa sul totale
(vedi figura 2) della bolletta, per cui non ha molto senso agire lì.
- Ogni kWh eventualmente prodotto in eccesso al proprio fabbisogno energetico
domestico viene solo incentivato in conto energia e non porta vantaggio sulla
bolletta.
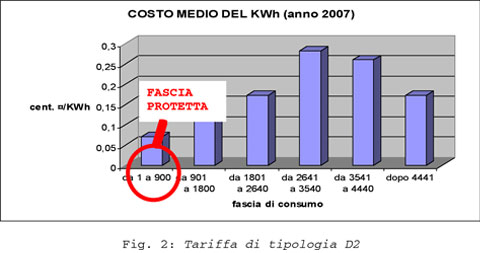
Funzionamento di impianti ad isola
Si ricorre a questa
tipologia di impianto solamente quando il fotovoltaico diventa un’esigenza.
Alcuni esempi possono essere: baite montane, camper, barche, case isolate e non
raggiunte dalla rete elettrica. Inoltre fanno parte di questa tipologia di
impianto anche tutte quelle applicazioni quali ad esempio l’illuminazione della
segnaletica stradale o l’illuminazione nei giardini domestici. In questo caso lo
schema di riferimento diventa quello di figura 3.
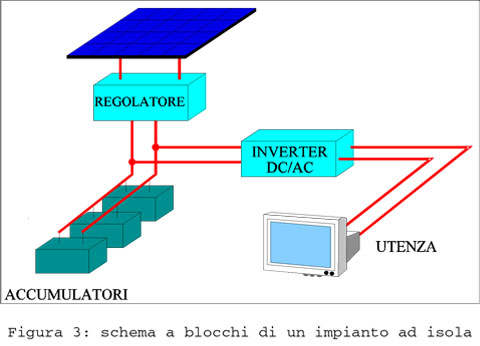
I componenti fondamentali di questa tipologia di impianto fotovoltaico sono i
seguenti:
- Pannelli fotovoltaici: trasformano l’irraggiamento solare
in corrente elettrica continua
- Convertitore statico: in questo caso il convertitore può
essere del tipo DC/DC (chopper) o DC/AC (inverter) a seconda delle applicazioni.
In alcuni sistemi, dove la tensione di alimentazione è già in linea con i moduli
fotovoltaici, il convertitore può non essere presente
- Regolatore di carica: è il dispositivo che in qualche modo
protegge gli accumulatori impedendo, ad esempio, che al loro interno si
verifichino eccessi di carica o scariche troppo veloci.
- Accumulatori: sono una parte fondamentale dell’impianto ad
isola, infatti sono loro che accumulano l’energia necessaria quando i moduli non
sono in grado di produrne a causa delle condizioni ambientali (ad esempio nelle
giornate estremamente nuvolose o nelle ore notturne). Il problema principale di
questi componenti è che a causa dei frequenti cicli di carica/scarica devono
essere sostituiti almeno 3 o 4 volte nel tempo di vita dell’impianto (circa 25
anni).
Dimensionamento di un impianto fotovoltaico
Per
progettare correttamente un impianto fotovoltaico si devono considerare due
aspetti principali:
Dal punto di vista economico, infatti, è possibile oggi ricorrere a molti
incentivi statali o comunali (per esempio per gli impianti connessi in rete è in
vigore il decreto denominato “Conto Energia”) e a volte persino regionali. Può
succedere che questi siano incompatibili tra di loro, oppure no. Per poter
accedere a tali finanziamenti è necessario, chiaramente, presentare una
documentazione appropriata.Dal punto di vista tecnico, invece, si deve tener
conto di diversi fattori. I principali sono:
- Dimensionamento appropriato al consumo medio annuo dell’utenza connessa
- Posizionamento ottimale dei pannelli sia in termini di inclinazione che in
termini di orientamento
- Determinazione del fattore di ombreggiamento a seguito di un accurato studio
delle ombre
- Dimensionamento del generatore fotovoltaico in accordo con le specifiche
dell’inverter
- Dimensionamento dell’accumulatore per garantire la giusta autonomia al
sistema ad isola
Altre tipologie di impianto fotovoltaico
Esistono, oltre
a quelle descritte, altre tipologie di impianto fotovoltaico, per esempio:
- Impianti orientabili: sono sistemi in grado di “seguire”
l’andamento giornaliero del sole garantendo così che i moduli siano sottoposti
alla migliore condizione di irraggiamento possibile. Questi impianti possono
muoversi o su un singolo asse o addirittura su più assi (in questo caso
correggono entrambi gli angoli fondamentali, tilt e azimut). A fronte di un
irraggiamento sempre ottimale, però, questo tipo di impianto ha un costo
iniziale elevato e richiede manutenzione continua nel tempo.
- Impianti a concentrazione: è la nuova concezione degli
impianti fotovoltaici. In questo caso si cerca di aumentare il rendimento delle
celle anche di fattori di diverse unità (10 – 50 ) attraverso a dei sistemi di
specchi e lenti (molto costosi) che di fatto moltiplicano il numero dei raggi
solari incidenti sulle celle (questa tecnica viene comunemente chiamata “i cento
soli”). In questo caso si può ridurre notevolmente l’area di silicio esposta al
sole. Le controindicazioni di questa tipologia di impianti, però, sono ancora
tante, ma la più problematica riguarda ilsistema di raffreddamento delle celle
indispensabile per garantirne l’integrità nel tempo.
- Sistemi per alimentazione diretta: in questo caso il
pannello alimenta direttamente il dispositivo a cui è associato, ma il sistema
non prevede la possibilità di immagazzinare energia. Di questa categoria fanno
parte, ad esempio, le calcolatrici solari.
Aspetti fisici del
fotovoltaico
Effetto fotoelettrico
L’effetto fotoelettrico è stato
osservato per la prima volta da Alexandre Edmond Becquerel nel 1839. Questo
effetto è legato alla proprietà di alcuni materiali semiconduttori,
opportunamente trattati, che riescono ad assorbire fotoni (particelle elementari
della radiazione solare caratterizzati da un’energia h*䀀) rilasciando
elettroni; questa conversione può determinare un flusso di corrente
elettrica.
Cella fotovoltaica
La cella fotovoltaica (vedi figura 4)
è l’elemento di base che costituisce i moduli fotovoltaici nella quale avviene
l’effeto fotoelettrico. La cella fotovoltaica è costituita da un sottile strato,
di circa tre decimi di mm, di materiale semiconduttore. Quasi sempre tale
materiale è il silicio (amorfo o cristallino) che, nonostante non si trovi
libero in natura, è l’elemento più diffuso sulla Terra dopo l’ossigeno. La fetta
di silicio viene, di norma, intrinsecamente drogata, mediante l’inserimento
nella struttura cristallina di atomi di tipo P, solitamente boro, e di atomi di
tipo N, spesso fosforo.
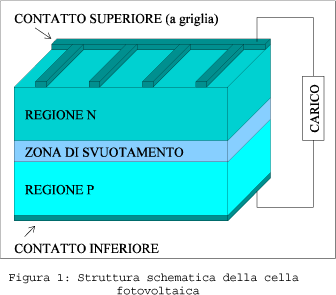
Nella zona di contatto tra i due strati a diverso drogaggio (zona di
svuotamento), quando la cella è esposta al sole, si generano delle cariche
elettriche, in misura tanto maggiore quanto più elevato è l’irraggiamento
solare. Attraverso a dei contatti elettrici posti alle estremità superiore ed
inferiore della cella è possibile collegare la cella stessa ad un utilizzatore
(carico) e così si avrà in esso un flusso di elettroni sotto forma di corrente
elettrica continua.
Vedi approfondimenti
fisici
Efficienza della cella fotovoltaica
Si caratterizza ogni
cella fotovoltaica in base alla sua efficienza che è definita come il rapporto
tra la potenza elettrica fornita rispetto all’irraggiamento solare. Tale
efficienza è limitata da vari fattori di perdita, quali ad esempio:
- Riflessione dei raggi solari incidenti
- Dispersione degli elettroni inizialmente eccitati dai fotoni che non
riescono a produrre corrente elettrica
- Resistenze parassite associate, ad esempio, ai contatti elettrici
Tipologie comuni di celle fotovoltaiche
Ad oggi, nel
mercato del fotovoltaico, si possono trovare comunemente tre tipi di cella con
caratteristiche differenti in base alla struttura del silicio che la
compone:
- Silicio monocristallino: è la cella che ha il rendimento
maggiore (compreso tra 13% - 16 %), ma anche il maggior costo. E’ ottenuta
partendo dai wafer di silicio purissimo monocristallino
- Silicio policristallino: è la cella costituita da silicio
caratterizzato da un grado di purezza inferiore rispetto al silicio
monocristallino. Il suo rendimento è leggermente inferiore (11% - 14%) a fronte
però di un costo inferiore.
- Silicio amorfo: è la cella costituita da un sottile strato
di silicio (film) che viene depositato chimicamente su un supporto. La forma
chimica dello strato non è più cristallina. Il rendimento di questo tipo di
cella è molto più basso rispetto al silicio cristallino (6%-8%), ma il costo è
nettamente il più favorevole.
In generale un’altra caratteristica delle celle fotovoltaiche cristalline è
che il loro rendimento si mantiene nel tempo tanto che oggi i costruttori
garantiscono che le perdite dei loro prodotti saranno inferiori al 20% dopo 25
anni. Per quanto riguarda le celle di silicio amorfo, invece, si hanno perdite
stimabili attorno al 30% nei primi due anni; solo dopo questo periodo il
rendimento delle celle amorfe mostra un assestamento quasi costante nel
tempo.
Pannelli fotovoltaici
Le celle fotovoltaiche sono quasi
sempre di forma quadrata (10 cm di lato), ma con gli spigoli leggermente
arrotondati. L’area della cella così composta è di circa 100 cm2 e le sue
caratteristiche elettriche a vuoto, cioè in assenza di carico, sono:
- Tensione 䀀 0.6 V
- Corrente 䀀 2 A
- Perogata = I*V 䀀 1.2 W
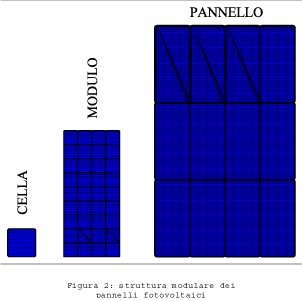
La cella costituisce la “mattonella” del pannello; in particolare più celle
in serie formano i moduli fotovoltaici (solitamente si cerca di avere moduli da
12 V o da 24 V), mentre l’assemblaggio di più moduli porta alla costituzione dei
pannelli fotovoltaici (vedi fig.5).
Caratteristica elettrica di una cella fotovoltaica
La
caratteristica elettrica corrente – tensione di una cella fotovoltaica
(considerata come un generatore di corrente) esposta ad irraggiamento ha
l’andamento stilizzato di figura 6.
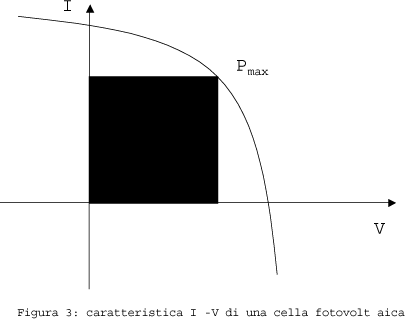
La caratteristica I-V delle celle è importante per determinare il punto di
lavoro in cui la cella offre massima potenza. In realtà la caratteristica
elettrica di figura 6 è influenzata da alcuni fattori esterni, quali ad esempio
l’irraggiamento solare e la temperatura di lavoro come mostrato in figura 7. In
particolare si nota come la potenza fornita dalla cella cali al diminuire
dell’irraggiamento solare e come, invece, il punto di lavoro ottimo si sposti al
variare della temperatura. Nella pratica, succede quasi sempre, che si cerchino
dei compromessi tra tutti i fattori in gioco.
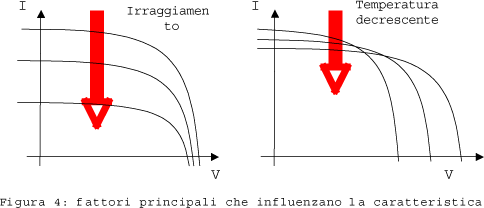
|